Così come l’albero unisce allegoricamente il cielo alla terra, il sacro al profano, il visibile all’invisibile – e congiunge quindi i tre mondi: di Dio, dell’uomo e della terra -, allo stesso modo il tronco dell’albero è percorso dal nostro anelito a cogliere l’origine delle cose, dallo slancio creativo verso la presentazione di sé e dei propri talenti, come emerge nell’arte di Paul Klee (1879-1940), pittore metafisico svizzero, che profondeva nelle immagini dei suoi quadri un fondamentale mezzo di rivelazione più che di riproduzione della realtà, dove la verità vera giace prima nel fondo invisibile.
Cos’è l’albero della buona impresa? E’ un albero che affonda le radici sul terreno solido e fertile dei valori vitali, cioè dall’humus da cui traggono lievito e alimento, come espresso nella metafora evangelica della vite e dei tralci (Gv 15, 1-8), i frutti. La vite carica dei grappoli d’uva, come l’impresa con la sua intelaiatura di molteplici funzioni (organizzative, gestionali, amministrative, commerciali, di marketing, di sviluppo delle risorse umane eccetera), costituiscono uno degli spettacoli più belli e naturali, ideati dalla provvidenza. Tralci e funzioni, ognuno nel loro specifico interesse, si arrampicano e si distendono mostrando i loro tipici prodotti, restando ontologicamente abbracciati e uniti al tronco. E poi i nodi: questi rappresentano i fatti cruciali presi in considerazione nel processo decisionale. La capacità di analisi della situazione sta proprio nel riuscire a determinare tutti i fattori da inserire nei nodi. Questi possono essere divisi in diversi livelli: quindi dai nodi possono svilupparsi ulteriori rami e ulteriori funzioni.
Forse questa è la più festosa metafora della fecondità e della produzione di ricchezza. E’ sufficiente un colpo di cesoia o uno squilibrio sul terreno, o un errore o un crollo che stacchi i tralci dal ceppo e lo spettacolo sarebbe completamente diverso. Sembra quasi impossibile che tutta quell’armonia, quella ricchezza di vita sia legata a una radice o a un’idea. Eppure è così: tutta quell’esuberanza di produttività è condizionata da un ceppo, da un supporto, da una creazione. Insomma, fuori di metafora, la vite è l’impresa e tutto ciò che gira intorno alla sua azione e alla sua vitalità, sono i tralci.
Le aziende di qualsiasi tipo, settore e dimensione presentano problematiche comuni. E’ possibile sviluppare il tema della buona gestione con riferimento non soltanto alle imprese, ma a qualsiasi realtà produttiva, perché tutte le aziende sono dedite alla produzione di beni o servizi utili al vivere individuale e collettivo e, in quanto tali, tutte devono confrontarsi con quattro ordini di problemi:
- servire i bisogni il cui soddisfacimento è la loro ragione d’essere;
- mobilitare le risorse occorrenti allo svolgimento dell’attività produttiva;
- realizzare un equilibrio economico-finanziario autoalimentantesi;
- avere una progettualità propria, un disegno che consenta di fronteggiare responsabilmente i fattori produttivi occorrenti, realizzando un equilibrio economico-finanziario sostenibile nel breve e nel medio-lungo termine.
E’ un errore comunque pensare che soltanto le imprese siano tenute a creare ricchezza e che la pubblica amministrazione, nelle sue molteplici articolazioni, e le aziende non profit ne siano invece esonerate e possano disinteressarsi dal rispondere alla domanda di maggiore qualità ed efficienza di ciò che producono. Né vale obiettare che per le attività di contenuto sociale e/o assistenziale sia difficile misurare il valore dei beni eseguiti o prodotti, dimenticando che non sono destinati al mercato ordinario per essere venduti o comprati, ma a una clientela che richiede maggiore responsabilità, attenzione e dedizione.
Quindi, come nel deserto un albero che cresce fa notizia, ben vengano e si moltiplichino le imprese non profit, le quali, adottando modelli organizzativi comunitari e collettivi, oltre a realizzare il giusto profitto, generano anche legami sociali e di amicizia. Il primo che introdusse l’idea di questa economia civile, come lui la chiamò, fu un abate: Antonio Genovesi, filosofo ed economista, docente di etica e metafisica a Napoli nella seconda metà del ’700. L’idea fondamentale è che l’homo oeconomicus si nutre anche di relazioni, motivazioni, fiducia. L’homo oeconomicus è sostituito dall’homo reciprocans, cioè dalla reciprocità, intesa come solidarietà, condivisione del comune benessere; la virtù attraverso la quale si genera la fiducia, principale pre-condizione dello sviluppo economico. Il suo principale intento era di diffondere nella società civile due concetti chiave: promuovere una cultura umanistica e la civiltà. Difatti, l’attività economica ha bisogno di virtù civili, deve essere finalizzata al bene comune, non esclusivamente all’egoismo individuale. Questo concetto, rilanciato dalla scuola di Friburgo alla fine degli anni ’30 del secolo scorso, si contrapponeva al dirigismo della politica, per un’economia in equilibrio fra libertà e giustizia. La dottrina sociale della Chiesa si è intrecciata con queste idee.
Le manifestazioni di “felicità” che rendono somiglianti tutte le organizzazioni gestite bene sono manifestazioni di uno sviluppo armonico, qualitativo prima ancora che dimensionale, che vede:
- i destinatari dei prodotti e servizi soddisfatti;
- i dipendenti contenti di lavorare per quell’impresa;
- i conti in ordine che consentono di far fronte agli investimenti (e, nel caso delle aziende profit, di rispondere alle giuste attese di remunerazione del capitale di rischio);
- i rapporti con ogni altro interlocutore improntati a stima e fiducia reciproca;
- un legame profondo con il territorio, come quello di un albero la cui cura non può prescindere da quella del terreno in cui esso affonda le radici e viceversa;
- e soprattutto, pur in presenza delle immancabili contrarietà e turbolenze che generano preoccupazione, un clima di serenità operosa.
Ma ciò che contraddistingue la buona gestione di un’azienda è il modo con cui viene ricercata l’unità in questa molteplicità di interessi, esigenze, obiettivi. E’ un modo fatto di un’armonia che non può mai essere data per acquisita, ma è di continuo ricercata e conquistata avendo come bussola il superiore interesse dell’azienda, concepita come un bene comune al cui buon funzionamento tutti sono interessati.
Ma che cosa vuol dire dedizione all’azienda? Vuol dire fondamentalmente due cose:
- avere a cuore il bene dell’azienda;
- identificare il bene dell’azienda con la sua funzionalità e il suo sviluppo duraturo.
Avere a cuore il bene dell’azienda significa – in ogni decisione e in ogni situazione, sia in quelle cruciali per i destini dell’azienda sia in quelle ricorrenti quotidianamente – riconoscere ciò che è bene e giusto per essa e cercare di farlo.
Identificare il bene dell’azienda con il suo sviluppo duraturo significa comporre a unità i molteplici interessi intorno al nucleo centrale dei destinatari finali dei beni e servizi, oggetto dell’attività produttiva e della valorizzazione dei collaboratori, e nell’innestare su tale nucleo centrale gli obiettivi di redditività e crescita e di soddisfazione degli interessi della proprietà e di ogni altro interlocutore.
Purtroppo è sotto gli occhi di tutti il contrario. Dopo la caduta del muro di Berlino (novembre 1989), l’utilitarismo ha spostato il “tiro” sull’egoismo, sul business is business, che è penetrato in quasi ogni persona del mondo come attività prioritaria. La situazione odierna non solo non fa eccezione, ma è ancora più complessa e complicata di una volta, perché influenzata dal fenomeno della globalizzazione. La finanziarizzazione dell’economia (nuovo paradigma economico che ha contagiato tutti per la facilità con cui si creava arricchimento, al di fuori dell’economia reale) ha fatto aumentare la ricchezza complessiva del pianeta, ma mal distribuita: mezza ricchezza globale è detenuta nelle mani dell’1% della popolazione. L’aumento degli squilibri economici nel mondo – che si riflette anche in Italia a causa di una crescente deindustrializzazione – richiede un cambio di paradigma. Il fatto che negli anni passati, alla crescita del profitto corrispondesse un miglioramento del benessere generale, ha portato a confondere mezzi e fini e ad identificare il profitto come l’obiettivo principale e ultimo.
In molte scuole di business ethics di matrice cattolica – ma anche laica – il problema viene affrontato dall’interno dell’azienda, applicando, rispettivamente, i principi della dottrina sociale della Chiesa o quelli fondati sulla logica delle facoltà umane. E così si sono fatti passi avanti, introducendo progetti filantropici o i codici etici di condotta ad uso interno e per la comunicazione pubblica. Ma poi basta un boom di borsa e il “denaro che produce denaro” con le dismissioni, le delocalizzazioni, le vendite di marchi, per comprendere che l’istinto speculativo non è scomparso, nonostante i codici di comportamento e i valori etici pubblicamente professati.
Papa Benedetto XVI prima – con le encicliche Deus caritas est (2005) e Caritas in veritate (2009) e Papa Francesco, poi, con l’enciclica Laudato sì (2017) hanno lanciato allarme e proposte. L’ultima iniziativa è l’incontro internazionale tra economisti e imprenditori al di sotto dei 35 anni programmato ad Assisi da Papa Francesco (probabilmente a novembre, n.d.r.), dal titolo significativo “The Economy of Francesco”, che non sarà un allarme, ma il segno di una positiva contaminazione di visioni ed esperienze diverse (economia sociale di mercato, economia civile, economia di comunione, economia della decrescita felice eccetera). Naturalmente il Papa non va alla ricerca di una “terza via” o di un modello sociale ed economico cattolico, ma si rivolge alle nuove generazioni di tutto il mondo perché, attraverso la formazione, lo studio, la ricerca e il discernimento, possano suggerire nuove teorie, nuovi paradigmi etici di sviluppo e nuove prassi, immaginando e costruendo un’economia dove prevalgano lo sviluppo sostenibile e l’ecologia integrale (economica, ambientale, sociale, culturale, della vita quotidiana, che protegge il bene comune e sa guardare al futuro).
In conclusione, qual è la caratteristica fondamentale del buon imprenditore? Joseph Schumpeter nella prima metà del secolo scorso diceva che era soprattutto l’innovazione; oggi, nell’era della globalizzazione, non è più sufficiente. Occorre anche l’anticipazione: prima ancora del mercato, egli deve intravedere, cioè vedere in lontananza, prevedere e anticipare. Come? Oltre che leggere e informarsi, osservando e ascoltando le persone per risolvere i loro problemi di sussistenza e rispondere alla loro domanda di servizi, come fecero i francescani nel XIII secolo nel concepire le ragioni dello sviluppo e aprire le porte ai fondamenti della scienza economica. Così facendo l’imprenditore realizza il mutuo vantaggio e, senza neanche accorgersene, il bene comune. La bellezza di fare impresa è questo intreccio morale e creativo!
Oreste Bazzichi è docente di sociologia economica alla Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura – Seraphicum (Roma), collabora a diversi periodici ed è membro della redazione della rivista della Fondazione Giuseppe Toniolo «La Società». Tra le sue pubblicazioni: Alle radici del capitalismo. Medioevo e scienza economica (2003); Dall’usura al giusto profitto. L’etica economica della Scuola francescana (2008); Dall’economia civile francescana all’economia capitalistica moderna (2015).


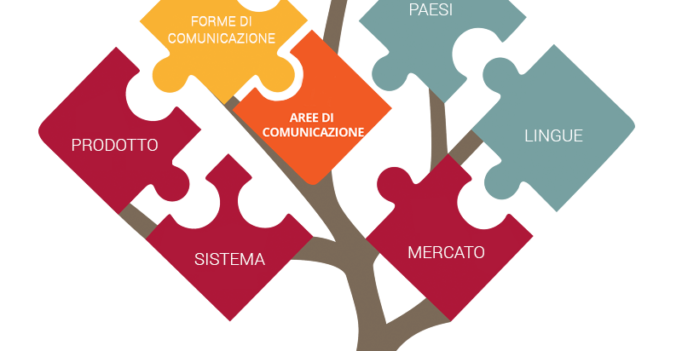
Be the first to comment